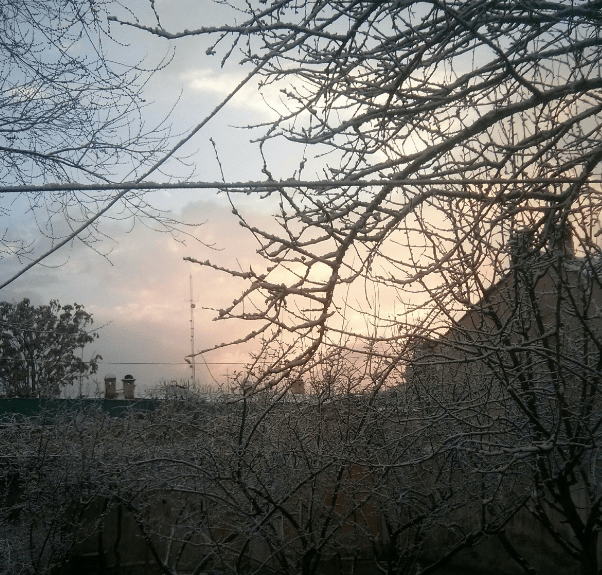Non capisco chi non capisce che la politica passa anche dalla pancia. Oltre alla visceralità dell’esistenza politica, per me ci sono anche sempre fattori contingenti che, per caso o per necessità, mi riconducono al perché di quello che ho scelto e di quello che per cui vivo.
Oggi l’occasione è stata una tazza di te salato, tipico del Kashmir e delle valli himalayane al di qua e al di là del confine contestato tra India e Pakistan.
Un paio di giorni fa ne parlavo con uno dei miei colleghi; lui viene da Hunza, una valle a 2500 metri d’altitudine nell’estremo nord del Pakistan. Discutevamo di variazioni regionali nelle ricette, di abitudini e tradizioni del te salato. Sapendo che mi piace molto, me lo ha preparato stamattina per colazione. Quello che lui chiama shur chai è una versione (con il burro e senza il bicarbonato) di quello che io conosco come noon chai e che per me rappresenta il sapore che associo col Kashmir. Mentre io bevevo la mia tazza, con la testa a Kabul e il cuore a Srinagar, lui ha riempito una ciotola con pezzi di pane vecchio, poi ha versato il te e lo ha mangiato come una zuppa, pensando con nostalgia alle colazioni di quando era bambino.
La mia tazza di shur chai mi ha messo di fronte a quello che da giorni cercavo di evitare.
Sono quarantatré giorni che sento il bisogno di scrivere di quanto sta succedendo in Kashmir, ma ogni giorno che passa rende più difficile trovare le parole. Ho continuato a procrastinare, incapace di affrontare l’impensabilità di tanto orrore. E con ogni giorno che passa cresce il senso di colpa perché sento che il mio silenzio diventa complice.
Sono quarantatré giorni che la Valle è sotto assedio. Dopo l’uccisione del giovane comandante di uno dei gruppi ribelli che combattono il controllo indiano in nome dell’autodeterminazione, il Kashmir è insorto e l’India ha risposto col pugno di ferro. Con una violenza inaudita e difficile da comprendere. In quarantatré giorni sono state uccise quasi settanta persone e centinaia sono state colpite, per lo più agli occhi, da fucili ad aria compressa. Fuor di metafora, l’esercito indiano sta sistematicamente rimuovendo la possibilità di guardare al futuro in maniera diversa da quella immaginata da chi sta al potere. Nei giorni scorsi il coprifuoco è stato esteso tanto al giorno che alla notte, rendendo praticamente impossibile anche solo comperare il latte. L’altro ieri è stata impedita la distribuzione di carburante e hanno sparato all’autista di un’ambulanza che trasportava dei feriti all’ospedale. Penso ai miei amici lì, a chi ha un posto molto speciale nel mio cuore, alle madri degli adolescenti che protestano per le strade. Alla rabbia, alla paura, al diritto di scegliere e di decidere per se stessi.
Come si scrive di tutto questo? Dove si trovano le parole? Oggi un amico mi ha detto che scrivere è inutile perché in tempi come questi non ci resta niente da aggiungere. Forse è vero, non ci sono parole che possano dare la misura dell’orrore e quello che scrivo è irrilevante, ma mai come adesso il silenzio mi sembra colpevole.
A volte vorrei tanto vivere in un mondo semplice in cui una tazza di te salato potesse essere sufficiente per cominciare a cambiare le cose.